Clerico-Fascista a chi?
Questo articolo vuole ricollegarsi alla traduzione precedente, concernente la figura di Padre Jozef Tiso, sacerdote e presidente della prima Slovacchia indipendente. Si tratta di una traduzione di un saggio di Richard J. Wolff della Columbia University, tratto dagli archivi della American Catholic Historical Society of Philadelphia.
Mi sembrava interessante ampliare la trattazione della figura di Padre Tiso. In realtà, questo articolo, come dice il titolo, tratta della relazione fra i governi Slovacco e Croato e la Chiesa Cattolica durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale; e della tensione derivante dal fatto che, per ovvi motivi strategici, la politica dei due paesi fosse imperniata sull'Asse. Cioè, l'articolo non tratta direttamente del Vodca (leader) Tiso, ma dà un'ottima idea del contesto difficilissimo nel quale egli, allo stesso tempo sacerdote e capo dello stato, dovette operare.
Qui pubblicherò solo la prima parte, appunto solo quella che si riferisce alla Slovacchia e, per la precisione, tratta delle relazioni fra il governo slovacco, il Cancelliere Adolf Hitler, i suoi emissari in Slovacchia e la gerarchia ecclesiastica nazionale la quale doveva, giustamente, rendere conto delle sue azioni al Vaticano.
L'autore è un americano e, come tale, è molto attento a non dare l'impressione di parteggiare per gli slovacchi né, Dio gliene scampi, per i tedeschi. Per esempio, scrive cose tipo: "...il comportamento del clero Cattolico in Slovacchia, nei rapporti col nazismo, non fu sempre irreprensibile come la preponderanza delle prove potrebbe far credere." Cioè le prove sono preponderanti, ma non lo sono?
Ciònonostante, l'articolo offre spunti interessantissimi a chiunque, senza pregiudizi, voglia approfondire l'argomento.
L'illustrazione sotto al titolo è di Edmund Massányi. 1943. 14 marzo 1939, la Slovacchia diventa indipendente. "Questo è il giorno fatto dal Signore: Rallegriamoci ed esultiamo in esso!" (Salmi 117, 24)
Ogni vostro commento sarà, come sempre, molto gradito.
L. Pavese
La chiesa cattolica e le dittature in Slovacchia e in Croazia, 1939-1945
Di Richard J. Wolff
Introduzione
Nell'introduzione alla sua raccolta di saggi sul fascismo europeo, S.J. Woolf (1936-2021) fece notare la diffusa inesattezza accademica che è diventata ormai sinonimo del termine “fascista”. Oggetto d’abuso da parte degli storici marxisti e “tradizionali”, questa parola è ormai divenuta inseparabile dalla polemica che la circonda.
Scrive Woolf:
“Forse la parola fascismo dovrebbe essere esclusa, almeno temporaneamente, dal nostro vocabolario politico. Perché, come di altre parolone quali: democrazia, reazionario, radicale, anarchia, se ne è tanto abusato che ha perduto il suo significato originale”[1].
La natura
controversa di certe erudite dichiarazioni concernenti il sistema politico del
periodo fra le due guerre mondiali, conosciuto come “fascismo”, si è involuta
ulteriormente con l’introduzione di concetti “chiarificatori” quali, ad esempio, “clerico-fascismo”, col quale si definisce il regime interbellico
vigente nell’Austria indipendente e i sistemi politici di entrambe la
Slovacchia e la Croazia durante la seconda guerra mondiale.
Nella sua opera del 1948 sull’Austria dopo la prima guerra mondiale (Austria from Hapsburg to Hitler), Charles A. Gulick (1896-1984) introdusse questo particolare concetto di fascismo ibrido, cioè il clerico-fascismo; ma nel corso di quasi duemila pagine non riuscì mai a darne una definizione. È come se l’autore avesse semplicemente dedotto il concetto da una descrizione dell’Austria sotto Dollfuss o Schuschnigg; perché nei suoi tentativi di dimostrare come il sistema “non fosse solo Fascista, ma anche clericale,[2]” Gulick si riduce, in fondo, a citare una litania di presunte offese contro i principi “democratici”:
“Pianificazione intenzionale del doppio processo, e punizioni multiple per lo stesso reato; un commissario col potere economico di vita o di morte; norme sulla stampa per nascondere i fatti...; sabotaggio delle leggi sociali, dominazione dei sindacati da parte dello stato; ingiusto spostamento della pressione fiscale...; sostituzione del diritto alla previdenza sociale con umiliante beneficenza.[3]”
Si può
dire che, nella tesi di Gulick, il cruciale collegamento fra clericalismo e Fascismo non venga mai cristallizzato, ma rimanga solo un collegamento tenue e
quasi artificioso.
Siccome è chiaro che il concetto di sistema clerico-fascista potrebbe essere attribuito solo ad alcuni governi dell’Europa centrale ed orientale, va da sé che gli storici interessati a questi paesi in particolare, l’Austria, la Slovacchia e la Croazia, cerchino di formulare una definizione sensata di quel fenomeno politico. Per esempio, Fritz Feller, nel suo saggio “The Background of Austrian Fascism” sostiene che esiste “un chiaro collegamento spirituale” fra il totalitarismo e il Cattolicesimo e che:
“...le persone che sono cresciute in una ininterrotta tradizione cattolica sviluppano un certo modo di pensare, un determinato schema di concezioni dei rapporti umani i quali rendono possibile, una volta perduti i contenuti della loro tradizione religiosa, rimpiazzarli con una ideologia fascista altrettanto inconfutabile.[4]”
A prima
vista questa generalizzazione sembrerebbe abbastanza corretta; ma tuttavia è
estremamente dubbio che i popoli della Croazia e della Slovacchia, e gran parte
del loro clero, avessero dimenticato “i contenuti della loro tradizione
religiosa”. O che il comportamento di Don Luigi Sturzo in Italia, e l’alta
percentuale di funzionari cristiano-protestanti nei gruppi fascisti ungheresi
possa essere spiegato con un intrinseco collegamento Cattolico-Fascista. Ci
ritroviamo quindi nuovamente,quindi, con una definizione imprecisa di
“clerico-fascista”.
Per finire, in un saggio prodotto per la Bergen Conference on Comparative European Nazism and Fascism in Norway, lo storico Slovacco-Israeliano Yeshayahu Jelinek (1933-2016) propose ai colleghi la sua interpretazione di questo termine molto abusato:
“Mi
sembra che questo termine, clerico-fascista, potrebbe essere considerato
appropriato se: 1) in un sistema a partito unico 2) governasse un partito autoritario
dell’estrema destra il quale fosse 3) influenzato formalmente o informalmente
dalla Chiesa Cattolica e 4) promuovesse gli obiettivi della Chiesa specialmente
nel campo spirituale e religioso[5]”.
La
definizione del clerico-fascismo di Jelinek, che curiosamente non viene
ripetuta nel suo lavoro successivo sulla Slovacchia[6],
pare però un po’ tronca per via del fatto che manca di un qualsiasi
riferimento, diretto o indiretto, al concetto di fascismo. La sua
identificazione del clericalismo è ovvia, ma il punto è, e rimane, come far
coincidere il clericalismo con i principi fondamentali del Fascismo.
Se ogni
tentativo appare come un esempio di impossibile giocoleria ideologica, non
dovremmo allora, per il bene della precisione storica, dismettere completamente
l’espressione “clerico-fascista”, invece di violentare il linguaggio per mezzo
di una miscela di contraddizioni?
Per
quanto riguarda la nostra trattazione della Slovacchia e della Croazia, le
difficoltà inerenti all’adottare senza riserve l’etichetta “clerico-fascista”
sembrano abbastanza grandi da legittimarne l’abbandono[7].
Eppure,
semplicemente perché rifiutiamo il concetto generale di clerico-fascismo, e in
particolare la sua applicazione nel contesto della Slovacchia e della Croazia,
ciò non altera il fatto che i regimi bellici di Padre Jozef Tiso in Slovacchia
e di Ante Pavelić in Croazia fossero ostentatamente cattolici, e siano stati
influenzati in modo significativo dal clero cattolico romano; e si siano resi
colpevoli, in misura variabile, di eccessi crudeli verso gli ebrei e, nel caso
della Croazia, contro i non-cattolici.
Il
carattere confessionale di detti governi ha reso la Chiesa Cattolica,rappresentata dalle gerarchie locali e dal Vaticano, particolarmente
vulnerabile alle critiche per essersi associata con i peggiori elementi "fascisti". Edmond Paris (1894-1970), per esempio, in un suo studio, molto letto, sulla
Croazia sotto Pavelić denuncia la chiesa croata e Roma, in quanto architetta
primaria, come responsabili del massacro dei serbi ortodossi i quali furono
“destinati allo sterminio da un governo e da una gerarchia religiosa del
ventesimo secolo...”[8]
Ma una lettura attenta dell’opera di Jelinek sul suo Parish Republic (La
repubblica parrocchiale) rivela quanto l’autore sia confuso riguardo al caso se la chiesa abbia
facilitato oppure ostacolato i soprusi del governo croato.
Però,
benché i quesiti che circondano il ruolo della Chiesa in Slovacchia e in
Croazia siano molti e complessi, è tuttavia possibile giungere a certe valide
conclusioni per mezzo dell’uso giudizioso delle prove documentali e al ricorso
selettivo a fonti individuali secondarie. Entrambi i Documents on German
Foreign Policy e gli Actes et Documents du Saint Siège Relatifs à la
Seconde Guerre Mondiale sostengono la posizione che enfatizza il legame
intimo fra il Cattolicesimo e i soprammentovati stati europei ma che, allo
stesso tempo, dimostra la generale opposizione alle ideologie naziste e
fasciste da parte della gerarchia Vaticana.
Inoltre,
nonostante le tesi di Paris, Jelinek, Falconi ed altri, i documenti della
Cancelleria dell’Arcivescovo di Zagabria e del Vaticano propendono per
quest’ultima interpretazione (vedi: Richard Pattee, The Case of Cardinal
Aloysius Stepinac e Fiorello Cavalli “La Santa Sede contro le deportazioni
degli ebrei dalla Slovacchia durante la seconda guerra mondiale").
Bisogna
ammettere che un’indagine su questo argomento approderebbe a una vasta “zona
grigia” ma, cionondimeno, una rilettura efficace di ciò che è stato scritto
offrirebbe un punto di vista aggiuntivo su questo periodo molto controverso della
storia della Chiesa.
La Slovacchia indipendente, 1939-1945
Il
governo della Slovacchia indipendente sorse nel 1939 come prodotto
dell’interrelazione fra due forze differenti e a volte in conflitto fra loro:
le ambizioni nazional-socialiste nella regione del Danubio e il nazionalismo
slovacco, tutt’uno col carattere Cattolico della sua gente.
Benché il Partito Popolare Slovacco (in slovacco: Slovenská ľudová strana) di Monsignor Andrej Hlinka e di Padre Jozef Tiso fosse stato per vent’anni il campione dell’autonomia slovacca nel contesto dello stato cecoslovacco, era anche un fermo sostenitore dell’unità cecoslovacca, almeno sino alla spartizione del paese a Monaco, nel 1938. Durante la ribellione dei Tedeschi dei Sudeti nel settembre del 1938, e la conseguente mobilizzazione, anche se parziale, dell’esercito cecoslovacco, gli slovacchi e il Partito Popolare erano rimasti fedeli al governo nazionale:
“Kundt [inviato da Henlein] ...potè solo riferire che i radicali Populisti erano stati messi a tacere, e che il Partito Popolare apparentemente desiderava sostenere lo stato cecoslovacco.”[9]
Cionondimeno,
il sogno di un proprio stato aleggiava costantemente anche nelle teste dei
più moderati fra i membri del Partito Popolare polacco. Quando, fra il 1938 e
il 1939, lo stato cecoslovacco si disfaceva di fronte agli assalti diplomatici
tedeschi, i capi slovacchi divennero sempre meno entusiasti all’idea di
condividere il destino dei loro, non tanto apprezzati, fratelli cechi.
Agli
inizi del 1939, Adolf Hitler convocò a Berlino il primo ministro, recentemente
deposto, della Slovacchia autonoma, Padre Jozef Tiso e lo esortò a staccare
Bratislava dal groppone cecoslovacco.
Giocando
sulla paura che gli slovacchi avevano dell’irredentismo ungherese, Hitler
minacciò che, se gli slovacchi non avessero stabilito un percorso di vita
indipendente, egli sarebbe stato costretto a soddisfare le pretese territoriali
di Budapest.[10] Non c’è bisogno di dire
che il Fuhrer non dovette esercitare molta pressione sul consenziente leader
slovacco; e il parlamento di Bratislava rivelò i suoi sentimenti quando i
deputati eruttarono la loro approvazione mentre Tiso dichiarava: “Sono stato
ricevuto da Hitler con tutta la solennità concessa al capo sovrano di uno stato
indipendente.”[11]
E così,il 14 marzo 1939 la Slovacchia, sotto la guida di Padre Tiso e del Partito Popolare Slovacco, e con la protezione del Fuhrer, dichiarò la sua indipendenza da Praga.
 |
| Un futuro migliore in una libera Slovacchia! |
Non vi è
qui bisogno di riferire nei dettagli la natura del governo slovacco. Essendosi
dichiarato una repubblica, il nuovo stato garantiva diritti democratici solo in
teoria, perché il potere rimaneva fermamente nelle mani del presidente e del
primo ministro. Tutte le manovre politiche consentite avvenivano in seno al
Partito, ed erano risultato della relazione conflittuale fra la fazione conservatrice (di Padre Tiso) e
l’ala radicale e filonazista (di Vojetch Tuka e Alexander Mach). A lungo andare, ciascuna
controparte dovette fare delle correzioni per adattarsi alla realtà della
situazione: la corrente “clericale” di Padre Tiso riluttante ma costretta a
cooperare con il Nazismo e l’ala radicale di Tuka riconciliata con l’idea di
una difficile convivenza con i moderati e gli antifascisti conservatori.
 |
| Vojtech Tuka. Ministro degli Esteri slovacco |
Yeshayahu
Jelinek punta l’indice contro l’alta percentuale di prelati e religiosi
Cattolici-Romani nel governo della Slovacchia, come indicativa della sua natura
“clerico-fascista”[12],
ma, vista la notevole presenza del clero cristiano (sia Cattolico che
Protestante) nella vita nazionale slovacca, questo fenomeno sarebbe sorto
probabilmente anche in uno stato veramente democratico. Ciononostante, Jelinek,
coadiuvato da Liva Rothkirchen[13],
considera la presenza altamente visibile del clero Cattolico nel governo
slovacco come una manifestazione del sentimento filonazista della Chiesa, e
specialmente di Padre Tiso:
“Il prete [Tiso] era un astuto allievo del dittatore Nazista. Si manteneva molto informato sugli sviluppi della Germania, studiava i metodi nazisti e applicava le sue conoscenze a casa sua.[14]”
Eppure
persino i tedeschi non erano tanto convinti che il Vodca [leader. Cioè Tiso]
fosse particolarmente ben disposto verso la nazificazione della Slovacchia.
Hanns Elhard Ludin*, nominato rappresentante tedesco a Bratislava il 13 gennaio
1941, lamentava a Berlino che la maggioranza degli slovacchi conservava le
proprie “convinzioni cattoliche conservatrici,” e che passi avanti
dell’ideologia nazista in Slovacchia “potevano essere compiuti solo con
l’applicazione della forza bruta.”[15]
 |
| Hanns Elard Ludin. Ambasciatore tedesco in Slovacchia |
Inoltre, Hans Bernard, uno dei predecessori di Ludin, in un suo promemoria al Ministero degli Esteri tedesco espresse il suo totale disappunto per la politica estera di Padre Tiso sotto Ferdinand Ďurčanský,[16] e per le sue politiche nazionali in relazione alla “questione giudea”:
“Non si è giunti, in nessun senso, a una soluzione riguardo alla questione giudea. Di conseguenza, questi peggiori nemici della Germania sono ancora visti in Slovacchia come cittadini preziosi e indispensabili. Perciò, nel consiglio arbitrale della borsa valori di Bratislava, nominato di fresco lo scorso giugno, quattordici dei quarantuno membri, o il trentaquattro per cento, sono ebrei.[17]”
Padre
Tiso era consapevole del debito slovacco nei confronti della Germania e della
dura realtà del fatto che una Slovacchia indipendente non potesse esistere
senza l’approvazione del Fuhrer tedesco; ma, almeno nei primi anni del suo
governo, egli ribadì con enfasi l’aderenza del suo stato al Cattolicesimo,
ripudiando perciò tacitamente il Nazismo.
 |
| 1939. Trenčín, Slovacchia. Padre Tiso sul podio, durante un tour delle organizzazioni giovanili. |
Durante un convegno della Organizzazione degli Studenti Cattolici Slovacchi Padre Tiso dichiarò:
“Noi Cattolici non abbiamo bisogno di prendere lezioni da nessuno; abbiamo il nostro sistema...Quindi, il Cattolicesimo deve calarsi nella vita pubblica...Il Cattolicesimo deve guidare le politiche...Ogni altra politica è una politica da gangster. Senza la morale Cattolica non ci sarebbe cultura.[18]”
Poco
dopo, nel luglio del 1940 Tiso, Tuka e Mach furono convocati a Salisburgo per
incontrarvi il Fuhrer. Colà ascoltarono, mentre Hitler dichiarava che “...nella
sua politica nazionale, la Slovacchia deve aderire con lealtà e
inequivocabilmente alla causa tedesca.[19]”
Anche se è vero che le pressioni tedesche, sempre in aumento, e la genuina ammirazione di Tiso per l’acume politico di Hitler alla fine soffocarono le velate dichiarazioni anti-naziste del Vodca, l’opinione di Hoensch del carattere di Padre Tiso sembra essere concorde all’evidenza:
“Tiso era pronto a collaborare con la Germania nella sfera economica e in quella commerciale ma, in quanto sacerdote Cattolico e patriota, era fermamente contrario alla nazificazione e germanizzazione della vita slovacca”.[20]
Comunque,
emersero in Slovacchia alcune tendenze "fasciste", indipendentemente dalle
argomentazioni degli storici riguardo alla figura di Jozef Tiso.
L’esistenza
di elementi “fascisti” in Slovacchia è ampiamente riconosciuta, così come lo è
la presenza dominante del clero nella vita politica della nazione. Nell’ambito
diplomatico, la corrente clericale del Partito Popolare Slovacco trovava pochi
punti di disaccordo con la componente più radicale (almeno dopo
l'allontanamento di Ferdinand Ďurčanský), perché entrambe le fazioni
perseguirono in modo consistente una politica estera filo-tedesca.
 |
| Mach al centro (Ferdinand Ďurčanský alla sua sinistra, col cappello), durante un pellegrinaggio a Levoča. 1939 |
Persino
sul fronte nazionale slovacco la situazione non era tanto ben delineata quanto
si potrebbe pensare. Man mano che il destino della Slovacchia indipendente si
intrecciava sempre di più con quello della Germania, l’inflessibile posizione
anti-nazista dei cattolici slovacchi divenne sempre meno rigida.
Durante i primi due anni di indipendenza, vi furono numerosi episodi di protesta, da parte tedesca, contro il carattere decisamente cattolico dello stato slovacco. Come per enfatizzare lo speciale rapporto di Bratislava con la Santa Sede, Padre Tiso nominò ambasciatore l’antinazista Karol Sidor (1901-1953), e si rifiutò di richiamarlo nonostante le ripetute richieste tedesche. Già dalla metà del 1940, von Ribbentrop esprimeva questo desiderio al Barone von Killinger (nominato ambasciatore tedesco in Slovacchia il 30 luglio 1940):
“Inoltre, la prego di indurre il governo slovacco a richiamare immediatamente dal suo ufficio di Ministro presso il vaticano M. Sidor, in quanto politicamente inaffidabile”.[21]
Meno di sei mesi dopo, a novembre, von Ribbentrop tentò di nuovo di far esonerare Sidor per via dei suoi “sentimenti anti-tedeschi”,intervenendo personalmente presso il Primo Ministro slovacco Tuka:
“La relazione di Sidor era sfavorevole...Oltretutto, il suo atteggiamento personale era equivoco.”[22]
 |
| Karol Sidor mentre lascia il requiem per Papa Pio XI. 4/3/1939 |
Durante l’incontro con Tuka, von Ribbentrop non si limitò a fare obiezioni riguardanti l'ambasciatore Sidor, ma si lanciò anche contro il governo slovacco, colpevole di flirtare con il “Cattolicesimo politicizzato” e di essere troppo condiscendente verso preti con idee indipendenti.
Facendo eco alle parole di Hans Bernard, il quale, nel luglio precedente, aveva allertato Berlino contro “...la ricostituzione di un governo Schuschnigg” in Slovacchia,[23] il Ministro degli Esteri tedesco (von Ribbentrop) chiese che l’Azione Cattolica fosse soppressa:
“Il Cattolicesimo politico non può essere tollerato, perché ha avuto effetti devastanti...Ora che gli Slovacchi si erano finalmente organizzati, il Cattolicesimo internazionale si stava interessando a loro...Un pericolo emergerebbe solo se entrassero in scena Roma e il Cattolicesimo internazionale, e l’entourage del Papa...Anche se il rinnovamento dello stato slovacco era stato fatto grazie al lavoro del Partito Popolare, ora che l’indipendenza del paese era stata conseguita, il Partito era diventato un pericolo...Quindi al prete non deve essere più permesso di occupare una posizione di governo, o il terreno diverrebbe molto pericoloso.”[24]
I continui reclami dei ministri tedeschi presso Bratislava, e l’ovvio scontento di von Ribbentrop verso la situazione nazionale in Slovacchia indicano chiaramente che il clero slovacco era visto, a Berlino, come un ostacolo alla nazificazione della società slovacca. Allo stesso modo, la rimozione da uffici “ideologici” dei consiglieri tedeschi, nel 1941, e il loro confinamento a posti di carattere militare ed economico, dimostrano anche il livello di frustrazione della Germania nei suoi tentativi di introdurre il nazismo nella “Repubblica Parrocchiale”.[25]
Esaminando ora l'atteggiamento del Vaticano verso questo stato nitidamente cattolico, è ben noto che, sin dai primi giorni dell’indipendenza slovacca,la Santa Sede non vedesse con favore l’alta percentuale di preti coinvolti nella politica nazionale. Era infatti stata una politica costante di Papa Pio XI scoraggiare tale partecipazione da parte del clero; e perciò non deve sorprendere che il Sottosegretario di Stato, Monsignor Tardini, informò Berlino che “la Santa Sede non guardava con piacere” all’elezione di Padre Tiso alla presidenza della nuova Repubblica Slovacca.[26] Ovviamente, il Segretariato Vaticano era infastidito all’idea di dover sopportare le complicazioni dovute a un prete-presidente di un paese chiaramente allineato con la Germania.
È anche interessante notare tutte le volte che Tiso subì le conseguenze del discontento vaticano riguardo alle attività del suo governo. Per esempio, quando il Vescovo Scepusio richiese dal Vaticano il permesso di accettare una nomina governativa da parte di Padre Tiso, il Segretario di Stato, Cardinal Maglione rifiutò categoricamente.[27]
Il Vaticano continuò a dimostrare il suo disagio, man mano che la Slovacchia Cattolica rimaneva sempre più impigliata nella ragnatela tedesca. Quando, nel maggio del 1941, il nunzio pontificio a Bratislava, Monsignor Giuseppe Burzio informò la Santa Sede che il Vescovo I. Ferencik, in occasione del cinquantaduesimo compleanno di Adolf Hitler, aveva scritto un articolo elogiativo per il giornale Cattolico Tatransky Slovak, il Papa in persona prese un immediato provvedimento disciplinare.
Monsignor Montini (poi Papa Paolo VI), aggiunse la seguente nota scritta a mano al telegramma di Bruzio: “Sua Santità ha ordinato che il nome di Ferencik sia rimosso dall’elenco dei prelati nazionali (cosa già fatta).” [28]
Il
prete-presidente (Jozef Tiso) provò ancora il dolore della diretta pressione vaticana nell’autunno del 1941. In occasione della dedica di una nuova chiesa
in Považská Bystrica, il 7 settembre, il Vodca dichiarò di non vedere nessuna
contraddizione fra i principi nazisti e la dottrina sociale della Chiesa. La
cosa interessante è che fu il piuttosto indipendente ambasciatore slovacco in Vaticano,
Karol Sidor, che reclamò presso Monsignor Tardini, dicendo di essere
completamente perplesso e di non comprendere la concomitanza di due idee così
diverse. Ovviamente, il Vaticano stava provando le stesse difficoltà
filosofiche dell’ambasciatore slovacco; e Montini notò che, se le dichiarazioni
di Padre Tiso fossere risultate vere, sarebbe stato costretto a cancellare
anche il nome del presidente dall’elenco dei monsignori slovacchi.[29]
Naturalmente,
Padre Tiso non desiderava affatto rischiare una tale umiliazione pubblica, la
quale avrebbe anche seriamente danneggiato la sua statura politica in
Slovacchia. Inoltre, molto probabilmente era anche convinto di essere stato
malamente frainteso, perché era un prete troppo devoto per poter accettare
veramente l’ideologia nazista.
Il 12 novembre, Burzio riferì che Padre Tiso aveva reso una spiegazione pubblica dell’accaduto nella quale Tiso diceva di aver voluto solo paragonare gli aspetti “sociali” del nazional-socialismo con la teoria sociale Cattolica, e che la vera fedeltà dello stato slovacco era quella verso “...le encicliche papali e con le sue (del papa) spiegazioni dogmatiche e morali...”[30]
Questi
esempi di “ingerenze” vaticane nella politica della Slovacchia indipendente
dimostrano il vivo interesse col quale la Santa Sede guardava agli affari della
Slovacchia indipendente, come stato cattolico con un prete come presidente.
Ma il Vaticano aveva un formidabile rivale. La piccola Slovacchia veniva attirata verso due opposte direzioni da magnetismi di forza quasi uguale che emanavano da Roma e da Berlino.
Mettendo a contrasto le reiterate ma inefficaci proteste dei diplomatici tedeschi con gli influenti interventi della Santa Sede, risulta chiaro che, nella limitata misura in cui il Cattolicesimo battagliò col Nazismo in Slovacchia, dal 1939 al settembre del 1941, la Chiesa era riuscita a prevenire una significativa perdita d’influenza e persino a fermare i progressi nazisti in certi campi.[31]
Però, con la promulgazione del Codice Giudeo del 9 settembre 1941, la Chiesa soffrì un serio colpo e, di conseguenza, il Vaticano e la Chiesa slovacca diedero inizio a una fitta serie di attività con lo scopo di far pendere la bilancia del potere in Slovacchia a favore del Cattolicesimo.
Nel suo saggio sulla risposta vaticana alla questione giudea in Slovacchia, Liva Rothkirchen giunse alla conclusione che i governanti dello stato slovacco avevano compromesso il loro Cattolicesimo per ammansire i loro protettori tedeschi:
“Il loro
obiettivo principale era quello di guadagnarsi i favori del Fuhrer; dimostrare
la loro maturità ideologica diventando il primo stato a risolvere il “Problema
Giudeo”. Così facendo sconfessarono con leggerezza i principi Cattolici sui
quali il loro stato era stato presumibilmente fondato."[32]
Eppure, in questa osservazione della Rothkirchen vi è di più di un ovvio richiamo morale; perché essa allude alla tensione fra due idee in conflitto le quali usarono la Slovacchia come campo di battaglia. Per cominciare, Padre Tiso non avrebbe mai potuto “sconfessare con leggerezza” il suo Cattolicesimo, perché, nella sua mente, egli era prima di tutto e soprattutto un sacerdote; ma il dovere di un leader slovacco di preservare l’indipendenza del suo paese era primario; e la continuazione di una vera esistenza nazionale slovacca dipendeva in larga parte dall’essere gradito ad Adolf Hitler più che a Papa Pio XII.
Quindi,
l’ultima prova di forza fra la Chiesa e il Nazismo in Slovacchia fu incentrata
sul conflitto riguardo alla sorte degli ebrei. Sentendosi messa sotto pressione
dall’insoddisfazione tedesca per la mancanza di “progressi” slovacchi in questo
campo, il 9 settembre 1941 Bratislava emanò il Codice Giudeo, basato su
principi razziali e tanto severo quanto le Leggi di Norimberga tedesche del
1935.
A cagione
della reazione sfavorevole della Chiesa Cattolica alla promulgazione del Codice
Giudeo[33],
l’ambasciatore Karol Sidor fu istruito di sottolineare al Vaticano le origini
straniere della legge. Sidor lo fece nell’ottobre del 1941, spiegando che la
nuova legge contro gli ebrei non rappresentava il sentire del popolo slovacco,
ma era stata imposta alla Slovacchia dalla Germania. Però Monsignor Tardini non
fu convinto della spiegazione di Sidor, e infatti, l’ambasciatore slovacco, sottoposto
alle pugnaci domande del Sottosegretario di Stato Vaticano, fu costretto ad
ammettere che il Codice fosse “...contrario ai dettami Cattolici”.[34]
Il 12
novembre, circa tre settimane dopo questo incontro, il Cardinal Maglione
protestò ufficialmente contro il Codice Giudeo presso il governo slovacco,
facendo notare al presidente Tiso come fosse “...con enorme tristezza” che la
Santa Sede dovesse essere testimone della promulgazione di una legge che era
“...in aperto contrasto con i principi Cattolici,” in un paese prevalentemente Cattolico.[35]
Non c’è bisogno di dire che Vojtech Tuka e Alexander Mach non accolsero bene l’intervento della gerarchia Slovacca e di quella Vaticana nella questione; ben sapendo che ripetute proteste e richiami rivolti al presidente Tiso da parte dei suoi superiori religiosi non sarebbe stati ignorati, nonostante l’ovvio patriottismo e la comprensione che il presidente aveva della realtà politica.
Le
deportazioni degli ebrei verso la Galizia cominciarono agli inizi del
1942.
Monsignor
Bruzio rivelò, in una lettera al Primo Ministro slovacco Tuka, di essere ben
informato riguardo alla destinazione finale di quegli ebrei:
“...è un
errore credere che gli ebrei saranno inviati in Polonia a lavorare; in realtà
là verranno sterminati.”[36]
Il 14
marzo, Sidor fu convocato al Vaticano, e gli fu consegnata una nota che
protestava ufficialmente le deportazioni che si stavano effettuando in
Slovacchia, senza nessun riguardo per religione, sesso o età.
Trascorsa
meno di una settimana, dopo aver ricevuto un rapporto dal nunzio apolistico a
Bratislava, che forniva i dettagli dei piani per la rimozione di migliaia di
giovani ebrei, di età fra i sedici e i venticinque anni, il Cardinal Maglione
diede istruzioni al suo rappresentante di intervenire direttamente presso il
presidente Tiso, "...appellandosi ai suoi sentimenti di sacerdote.”[37]
Le
proteste Vaticane continuarono per tutta la primavera del 1942, con Karol Sidor
che cercò ripetutamente di giustificare il comportamento del suo governo, e
Maglione che diventava sempre più spazientito di fronte all’aumento del flusso
di ebrei slovacchi verso i campi di concentramento.[38]
I vescovi
slovacchi, incoraggiati dalla fermezza del Vaticano, aggiunsero la loro voce in
opposizione.
In un
articolo d’aprile, sul Katolicke Noviny, la gerarchia
ecclesiastica slovacca condannò con forza il trattamento degli ebrei Cattolici
e di tutti gli altri ebrei, indipendentemente dalla loro religione, “...i quali
sono esseri umani e devono essere trattati con umanità.”[39]
Gli
elementi filonazisti nel governo slovacco non incassarono gli attacchi da parte
delle istituzioni ecclesiastiche senza rispondere; e, in una lettera
all’Arcivescovo Kmet’ko, Tuka criticò il clero slovacco per aver protetto gli
“interessi degli ebrei e, in molti casi, anche quelli degli ebrei non
battezzati.”[40]
Anche se
abbiamo pochissime prove, quasi nessuna, riguardo alle opinioni personali di
padre Tiso, sappiamo che il suo potere non era illimitato, e che gli sarebbe
stato molto difficile fermare subitamente le deportazioni dovendosi confrontare
con i tedeschi e con l’opposizione slovacca. Ma, dato che né i tedeschi né la
cerchia intorno a Tuka e Mach sarebbero stati persuasi a porre fine alle
deportazioni semplicemente dalla disapprovazione del Vaticano e della gerarchia
ecclesiastica slovacca, è molto probabile che la fine della persecuzione
anti-israelita, nel giugno del 1942, sia dovuta all’opera di Padre Tiso e dei
suoi alleati clericali.
Giunse un
periodo di calma, che durò fino al febbraio del 1943, quando il filonazista
Ministro degli Interni slovacco Alexander Mach avvisò che non si era ancora
vista l’ultima delle deportazioni e che “verrà marzo, verrà aprile e i trasporti
si rimetteranno in moto.”[41]
La
gerarchia ecclesiastica slovacca sporse immediatamente un reclamo presso lo
stato, al quale seguì una Lettera Pastorale (che fu letta in tutte le chiese il
22 marzo 1943), la quale denunciava la proposta ripresa delle deportazioni come
“anti-Cristiana e illegale.”[42]
Allo
scopo di rafforzare la posizione dell’Episcopato e aumentare la pressione sul
governo slovacco, fu affidato a Monsignor Burzio il compito di comunicare
verbalmente a Vojtech Tuka una dura protesta. Monsignor Burzio fu accolto dal
Primo Ministro slovacco con un'invettiva piena d’insulti, che il nunzio
apostolico descrisse come estremamente offensiva.[43]
Ciononostante, egli eseguì le sue istruzioni con calma ed espresse la condanna
per il trattamento “da criminali, delle migliaia di donne e bambini innocenti
che erano stati deportati durante lo scorso anno.”[44]
Chiaramente
molto imbarazzato dal truce comportamento del suo Primo Ministro, Padre Tiso
redarguì Tuka molto severamente e poi sconfessò le sue affermazioni più
offensive. I trasporti non si rimisero più “in moto” con l’approvazione del
governo slovacco, e Padre Tiso rimase fedele al suo impegno con la Santa Sede.
Eccettuato
un breve periodo d’incertezza nel 1944, che risultò in una breve serie di ammonizioni
da parte del Vaticano, la Chiesa sembrò essersi rassicurata che i restanti
ventimila ebrei slovacchi (ne erano stati deportati circa settantamila) sarebbe
stati al sicuro sotto la protezione dello stato slovacco.
Naturalmente,
il comportamento del clero Cattolico in Slovacchia, nei rapporti col nazismo,
non fu sempre irreprensibile come la preponderanza delle prove potrebbe far
credere.
Proprio
perché era un sacerdote, e allo stesso tempo capo dello stato, Padre Tiso
coinvolse la Chiesa nelle efferatezze naziste.
Spesso egli proclamò a viva voce l’intimo collegamento fra stato e Chiesa, e così facendo attribuì al Cattolicesimo slovacco un certo grado di responsabilità.
“In Slovacchia, il Cattolicesimo gode di molta influenza in politica ed è pronto a prendersi le sue responsabilità. È pronto persino al martirio.”[45]
Eppure, nonostante
le azioni e i conflitti interiori di Padre Tiso e di altri prelati slovacchi,
la Chiesa Cattolica, rappresentata dal Vaticano e dalla gerarchia ecclesiastica
locale, reagì molto sfavorevolmente quando si rese conto che l’infelice valzer
che il governo slovacco ballava col nazismo stava conducendo pericolosamente
verso le nozze.
Portando molto spesso all’esasperazione i tedeschi e gli slovacchi filonazisti, la Chiesa dimostrò la sua fondamentale riluttanza a trattare con il Nazismo.
In una nazione Cattolica quanto la Slovacchia, pur con un governo che aderiva ai principi sociali della Chiesa, fu inevitabile che qualche membro del clero, in quel periodo storico, offuscasse la reputazione della Chiesa; ma, in generale, è chiaro che la gerarchia ecclesiastica slovacca e Vaticana furono un argine particolarmente efficace contro la totale nazificazione dello stato indipendente della Slovacchia.
Richard J. Wolff. Columbia University.
L’autore desidera ringraziare il professor Jorg K. Hoensch della Universitat des Saarlandes, Germania per la sua critica, i suoi suggerimenti e la revisione di questo articolo.
[1]
S.J. Woolf, European Fascism (New York: Random House, 1968), pag.1
[2]
Charles A. Gulick, Austria from Habsburg to Hitler (Berkeley,
California: University of California Press,1948) II: 1569
[3]
Charles A. Gulick, Austria, II: 1569
[4]
Fritz Fellner, “The Background of Austrian Fascism” nel Native Fascism in
the Successor States, Peter Sugar. Ed. (Santa Barbara, California: ABC
Clio, Inc., 1971) pag. 17-18
[5] Yeshayahu
Jelinek, “The Clergy in Politics During WWII Slovakia and Croatia: A
Comparison”, manoscritto non pubblicato, pag.24
[6]Yeshayahu
Jelinek, The Parish Republic (New York: Columbia University Press, 1976)
[7] Né Jörg
K. Hoensch né
Joseph F. Zacek, importanti storici dello stato Slovacco, hanno voluto
caratterizzare il regime di Padre Tiso (1939-1945) come clerico-fascista. Il
professor Hoensch ha evitato deliberatamente di usare il termine nelle sue
pubblicazioni sulla Slovacchia; e il professor Zacek ha inequivocabilmente
rifiutato questa etichetta in favore di “nazionalista-conservatore” o
“reazionario nationalista. D. Djordjević e I. Avakumovic sul “Croatia under the
Ustashi” hanno agito in modo analogo.
[8] E.
Paris, Genocide in Satellite Croatia (Chicago: American Institute for
Balkan Affairs,1962),pag.5
[9]
Josef Anderle, “The Establishment of Slovak Autonomy in 1938”, in M. Rechcigl,
ed. Czechoslovakia Past and Present (The Hague, 1969) I:86.
[10]
Vedi: “Tisco’s Address to the Parliament”, 14 marzo 1939, in Milan Ďurica,
La Slovacchia e le sue relazioni politiche con la Germania (Padova:
Marsilio Editori, 1964) I: 186ff
[11] Ibidem,
p. 186
[12]
Y. Jelinek, The Parish Republic, p.52.
[13]
Liva Rothkirchen, “The Vatican and the Jewish Problem in Slovakia”, Yad
Vashen Studies (Jerusalem: Jerusalem Post Press, 1967) v. VI.
[14]
Y. Jelinek, The Parish Republic, p. 53
[15]
Jorg K. Hoensch, “The Slovak Republic 1939-1945”, in V. Mamatey e R. Luza,
Edizioni History of the Czechoslovak Republic (Princeton University
Press, 1973), P. 286
[16] Documents
on German Foreign Policy (da qui in poi: DGFP) X, 371/208093-95,Berlino, 22
luglio 1940, pag. 286
[17] Ibidem
[18] DGFP,
X, 371/208093-95, Berlino, 22 luglio 1940, pag. 269
[19] DGFP,
X, 371/208024-29, Berghof, 28 luglio 1940, pag. 347
[20]
J. Hoensch, “The Slovak Republic”, pag. 285
[21]
DGFP, X, 371/208088-89, “Foreign Minister to the legation in Slovakia”, 31
luglio 1940, pag.376
[22]
DGFP, XI, F5/0245-53; F6/0456-60, “Memorandum by H. Noack”, 24 novembre 1940,
pag. 696
[23]
DGFP, X, 371/208093-95, Berlino, 22 luglio 1940, pag. 269
[24]
DGFP, XI, “Memorandum by H. Noack”, 24 novembre 1940, pag. 698
[25]
Ciò
fu fatto su ordine di Hans Ludin. Vedi J. Hoensch, “The Slovak Republic”, pag.
286
[26] Actes
et documents du Saint Siège relatifs à
la seconde guerre mondiale (da qui in poi: ADSS), IV Affari Ecclesiastici
Straordinari (Da qui in poi: AES) 8074/39, 12 novembre 1939, pag. 115
[27]
ADSS, IV, Le Cardinal Maglione au chargé d’affaires a Pressbourg Burzio”, AES,
7157/40, 21 agosto, 1940,pag. 115
[28]
ADSS, IV, “Le chargé d’affaires a Pressbourg Burzio au Cardinal Maglione”,
AES, 4667/41. 20 maggio 1941, pag. 507
[29]
ADDS, V, “Notes de Mons. Tardini”, AES 7883/41, 21, 23 ottobre 1941, pag.274
[30] ADSS,
V, “Burzio to Maglione”, AES 477/42, 12 novembre 1941, pag.301
[31] Ovviamente,
vi furono alcuni campi della vita slovacca sui quali la Chiesa non sfidò
la Germania, quali l’economia, gli affari esteri e le questioni militari.
[32]
Liva Rothkirchen, “The Vatican and the Jewish Problem”, pag. 52
[33]
Il 7 ottobre i Vescovi slovacchi, con in testa il Vescovo Kmet’ko, protestarono
la promulgazione del Codice presso Padre Tiso, e ricordarono al Presidente che
“…la teoria materialista del razzismo è in diretto contrasto con gli
insegnamenti della Chiesa…”, F. Cavalli, “La Santa Sede…” Civiltà
Cattolica, v. III, 1961, pag.8.
[34]
ADSS, V, “Notes de Mon. Tardini”, AES 7883/41, 21-23 ottobre 1941, pag. 274
[35]
F. Cavalli, “La Santa Sede…” pag. 7
[36]
“Burzio to Tuka”, febbraio 1942, citato da L. Rothkirchen, “The Vatican and the
Jewish Problem”, pag. 37
[37]
F. Cavalli, “La Santa Sede”, pag. 11
[38]
Vedi “Memorandum of Cardinal Maglione”, 11 aprile 1942, citato da Cavalli,
pag.11
[39]
F. Cavalli, “La Santa Sede”, pag.12
[40] Ibidem,
pag. 13
[41] Gardista
(Bratislava), 9 febbraio 1943.
[42]
F. Cavalli, “La Santa Sede”, pag.14; L. Rothkirchen, The Vatican and the Jewish
Problem”, pag.44
[43]
F. Cavalli, “La Santa Sede”, pag.15
[44] Ibidem
[45]
Y. Jelineck, The Parish Republic, pag.81.
* Si fece più presto di quanto io non pensassi. Il mio nome venne chiamato. Quando attraversai la porta, Ludin non era più lì, dov'io l'avevo lasciato. Costeggiai il recinto sulla stada. Migliaia di persone stavano all'interno del recinto e mi seguivano con gli sguardi fissi. Tra loro stava Ludin, tra mille maschere un volto.
Hans Ludin venne consegnato alla Cecoslovacchia pochi giorni dopo. L'accusa contro di lui partiva dalla base che la separazione della Slovacchia dalla Boemia non era stato un atto conforme al diritto internazionale. L'accusa ignorò la circostanza che dopo la separazione diversi grandi stati furono rappresentati presso il governo di Tiso da diplomatici, l'Unione Sovietica sino allo scoppio della guerra russo-tedesca da un ministro, come il Reich. L'accusa rifiutò al ministro del Reich il carattere di un diplomatico, lo accusò di essere stato agente di una potenza nemica presso un governo di traditori. Hans Ludin venne condannato a morte.
Fu giustiziato col capestro il 20 gennaio 1948. Nella Cecoslovacchia questo supplizio avviene non già mediante impiccagione, bensì per strangolamento.
Hans Ludin, spaventosamente dimagrito nel suo vestito di flanella grigio divenuto troppo largo, ebbe il capestro messo intorno al collo. Il boia lo fece lentamente girare e stringersi. Hans Ludin soffrì durante i venti minuti. Le sue ultime parole furono un pensiero per sua moglie e per suo figlio Tille ed il grido: viva la Germania!
Da IL QUESTIONARIO di Ernst von Solomon. Edizioni Settecolori S.R.L. Milano (2021).


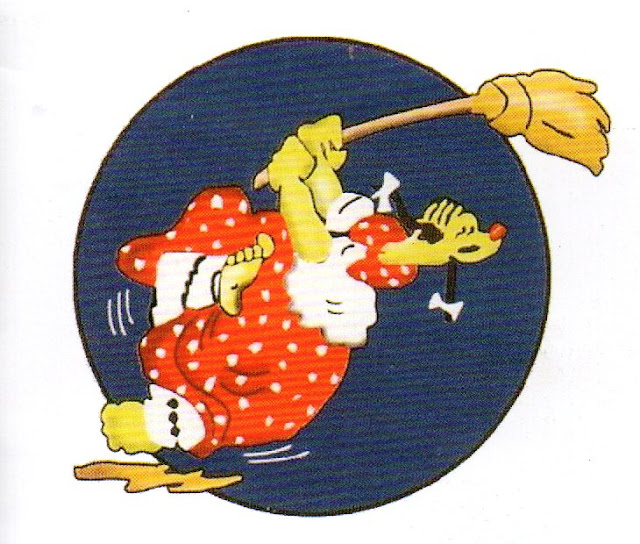


Comments
Post a Comment